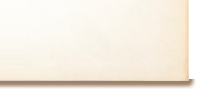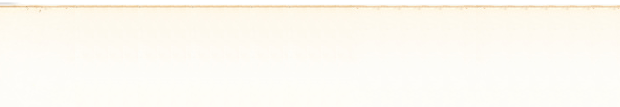
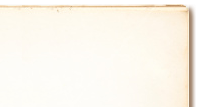

'o 'nciucio, ovvero :
La Larga Intesa per la Grande Riforma
------------------- Raffaele La Capria, ne L'Armonia Perduta, afferma che a Napoli la Rivoluzione del 1799 fallì, perché l'idealità della borghesia non seppe coinvolgere (come altrove è avvenuto) il popolo minuto, e rappresentarne gli interessi.
E descrive come poi, quel fallimento politico, abbia condizionato e connotato (negativamente) la cultura e la storia napoletana successiva, fino ad oggi.
Sono d'accordo con lui: è sicuramente vero.
Ma perché? Quali sono state le premesse storiche di quel disastro?
E dov'è la chiave per un possibile riscatto?
Io mi sono fatta un'opinione, e voglio raccontarla.
Quindi, torniamo insieme ad un'afosa e fuligginosa sera di luglio...
... questo breve racconto di argomento storico è del febbraio 1996; risente dell'attualità politica di quei giorni, e vuole evidenziare quanto le coscienze civili a Napoli fossero infervorate dal tema universale della partecipazione democratica (ed atterrite dal rischio di populismo demagogico) già un secolo e mezzo prima della Rivoluzione Francese.
Ogni riferimento a fatti, personaggi e situazioni storiche è assolutamente reale.
Ogni riferimento a fatti, personaggi e situazioni contemporanee è pura fantasia del lettore ...
Aprii la robusta porta di ferro e legno del Carmelo: uno spiraglio appena, e da quello mi sporsi con cautela a guardare per strada. La notte era calata a raffrescare la calda giornata di luglio, ma dal mare neanche un soffio si levava a scacciare l'acre sapore di fumo.
Riconoscevo nel buio sagome dei luoghi a me noti; ma non per questo, dopo i fatti di quella tragica settimana, meno inquietanti.
L'ampia spianata di piazza Mercato, oltre l'angolo del caseggiato dirimpetto, sebbene deserta e silenziosa, incombeva sinistra. Unica mia compagna era una lanterna ad olio; ma, più che portarmi conforto, temevo mi attirasse addosso ogni lazzaro o brigante appostato nello scuro.
L'attesa fortunatamente fu breve: prima sentii, poi finalmente vidi la carrozza scendere incerta sullo sconnesso acciottolato del Lavinaio.
Spalancai in fretta l'anta del portone mentre mi si fermava d'accanto. Tesi la mano ad afferrare quella guantata ed anellata che, dall'interno, chiedeva aiuto per scendere.
Monsignor Ascanio Filomarino si districò goffamente per l'angusto varco della portiera; quando finalmente mi fu ritto dinnanzi sulla strada, mi chinai a baciare la mano che ancora stringevo. «Presto, presto!» fece lui.
«Di qui, di qui!», risposi, precedendolo attraverso il portone, che richiusi alla svelta alle nostre spalle senza punto curarmi di dare indicazioni ai serventi ed alla scorta del cardinale.
La fioca luce della mia lanterna ci precedeva, ora pallida attraverso atrii e sale, ora lucente per corridoi e bianche scale; senza una parola attraversammo il chiostro.
Il convento era muto e deserto.
La pesante figura del porporato mi seguì, fino a fermarci dinnanzi all'uscio dell'appartamento del padre generale. Bussai piano ed aprii, senza attendere.
Don Giulio Genoino sedeva allo scrittoio con la penna in mano, dinnanzi a pergamene e fogli di appunti; altri rotoli erano ammassati sulla panca, per terra, sotto la finestra, ed ingombravano anche il letto sul quale evidentemente il sant'uomo non si distendeva da molto.
Solo l'inginocchiatoio appariva sgombro da carte.
Don Giulio si volse, si alzò di scatto e ci venne incontro raggiante; la sua esile figura avvolta nel saio scuro s'incorniciava della luce della lampada da tavolo alle sue spalle, facendo risplendere come raggiera la rada canizie ed il pallido incarnato della testa.
La evidente contentezza di Genoino fece incupire ancor più il cardinale che entrò risoluto mentre io, chinando il capo, mi facevo da un lato.
I due si abbracciarono; poi don Giulio si inginocchiò; chiuse una mano del cardinale tra le sue scarne ed affilate, e la baciò. Io ero entrato nell'appartamento, e cercavo di sgombrare dai documenti un largo sedile per fare accomodare l'ospite, mentre don Giulio con familiarità lo stava invece accompagnando al suo scrittoio.
L'anziano abate aveva cinto di un braccio bruno e sottile la spalla porpora e bianca immerlettata di pizzo del curvo e grosso prelato, e prendeva a raccontargli delle sue intense ricerche di quei giorni convulsi, delle tante speranze deluse, dell'aiuto più maldestro che ambiguo dei Palumbo e Perrone, delle visite quotidiane dei fratelli Carafa, del duca Diomede, dei sottili avvocati Mastellone e De Palma, delle molte antiche ed inutili carte a lui giunte dagli archivi di Stato che l'atterrito don Rodrigo d'Arcos, viceré di Spagna, aveva finalmente aperti alla sua consultazione dopo i recenti fatti crudeli.
I due mi voltavano le spalle e di me non si curavano certo; restai impalato tra la porta e il camino, con in mano le carte che avevo sollevate senza sapere dove posarle, incerto se stare o se andare per non volerli, col rumore dell'uscio, disturbare.
Don Giulio era sempre più lieto, ma non si avvedeva che negli occhi di Monsignore non c'era altrettanta della sua contentezza.
Gli raccontava di come in giornata Caracciolo avesse infine trovata, tra le carte fortunosamente traslate in San Paolo durante l'assalto dei lazzari e degli "alarbi" a San Lorenzo Maggiore, copia di un privilegio concesso al popolo della Città da Ferdinando di Spagna.
Il cardinale, sospinto dalla forza di quell'esile vecchio, sedette allo scrittoio e prese tra le mani il foglio coll'antico sigillo reale.
«Invero,» asseriva don Giulio: «non è la bolla di Ferrante d'Aragona di cui ho certa notizia, ma da quanto questa riporta son sicuro che a quella si ispira e conferma. Vedete, se raffrontate la prosa volgare con il testo latino di Melfi della Costituzione data da Federico secondo, riconoscete che il legislatore di re Ferdinando si ispira a documenti che leggeva in archivio.
«Sono certo di poter presto trovare conferma di quanto scrivo ed asserisco da anni, e che cioè l'Istituto deputato al dibattito per l'approvazione delle leggi che noi oggi chiamiamo Sedile (e nell'epoca lontana era il Tocco) discende da antica cultura radicata nel popolo nostro, che già forse tre mila anni fa aveva costruita Palepoli intorno alla sua agorà.
«Nell'attuale situazione di crisi potremo con faciltà tentar di convincere il viceré ad approvare un decreto che annunci le nuove elezioni del Sedile sulla base delle regole di parità che emergono da queste norme più antiche.
«Non saranno più a dettar leggi gli affamatori del popolo come i D'Angelo, i fratelli Naclerio, i borghesi eletti e rieletti per l'appoggio delle famiglie arricchite coll'esercizio di servizi dati in concessione dal re.
«Ecco, leggete» e spingeva altre carte tra le mani di don Ascanio: «basandomi sui miei studi io ho potuto ricostruire cinque capitolati a completare i ventitré del testo di legge che ho avuto stamane. Se Voi assecondate questo mio disegno, stesso domattina potremo compire quella grande opera di Riforma che Napoli attende, metter fine al disordine, dar nuovo corso alla politica e speranza alla ricostruzione.
«Pensate, Eminenza, alla Chiesa del Carmine gremita domattina di fedeli, all'annunzio che Voi darete di questo mio umile lavoro...»
«Codesto vostro lavoro» disse brusco d'un tratto il cardinale, con voce ferma ed attenta: «ha da cessare». Lasciando cadere la pergamena alzò il suo gelido sguardo negli occhi dell'altro, e terminò: «gia ché non porta buon frutto ad alcuno!»
Genoino ammutolì, incredulo.
Io restai, come pietra del muro a cui ero appoggiato.
L'abate si riscosse poi subito, ed incurvandosi ancora di più sul suo augusto interlocutore, prese ad incalzarlo pacato, con i più genuini argomenti:
«Voi, Eminenza, sapete quale affetto io abbia per questa Città e per il suo popolo che servii da eletto al Sedile in anni oggi lontani. Voi, Eminenza, avete sentito di come a quei tempi fosse florida ricca e festosa, abbondanti i raccolti del contado e la pesca del Golfo, ricolmi i mercati e fiorenti i commerci.
«In questi ultimi anni vedeste Voi stesso che la scarsa saggezza dei viceré (che regnano a Napoli per acquisirsi meriti a Madrid) ma più ancora l'ingordigia della nobiltà recente che accumula ricchezze per sé ai danni dello Stato senza alcun discernimento (quasi che i loro stessi rampolli non debbano poi avere a soffrire del debito che incombe su noi tutti) hanno portato il popolo a non avere altra scelta che tra la morte per inedia e la morte sulle barricate.
«Eppure, anche nei tempi lontani di cui dicevo, prima che conoscessi il carcere che mi avvicinò al Signore, anche da miscredente ho sempre sognato di un Tempo e di una Città di Giustizia.
«E come quando ero giovane, io oggi riprendo a vedere chiaramente che da domani ogni vico...» Genoino era ritto, e scrutava fuor di finestra, come se potesse davvero veder la Città, avvolta piuttosto nella notte senza luna: «...ogni Cardo che scende verso mare ferverà di alacre attività; e da ogni sua officina vedo riempir le botteghe affacciate sul Decumano di nuova merce prodotta.
«E vedo questa via dritta che (come già narra Pietro da Eboli dei tempi di Federico sovrano ed Imperatore), si prolunga ad oriente oltre Castel Capuano per le vie di terra. E ad occidente, oltre Castel dell'Ovo, sul mare.
«Ogni via, ogni viaggiatore, vedo passare in ogni suo viaggio sempre almeno una volta per Napoli, attraversarne il suo Decumano, ammirarne e acquistare le merci più nuove: vedo una Città Vetrina, intersecata ad angolo retto da una capillare Città Officina; in cui l'arte si apprende e continuamente si rinnuova per il segreto di aver racchiuso in ogni Cardo un differente mestiere.
«E vedo lavoro onorevole e onesto per tutti, non solo pei mercanti e i valenti artigiani, ma anche per i giovani lazzari e scugnizzi, che guadagnano la loro giornata a rifornir le officine di continuo di questa e di quella materia a richiesta, giacché i Cardi, per loro angusta natura, hanno insufficiente spazio di magazzino.
«E osservando d'ogni arte le regole, i più scaltri di essi ne apprendono i segreti che trasfomano poi in avveduti consigli per gli altri e sé stessi...»
Il cardinale riprese a parlare con voce ancora più ferma, senza mostrare di tenere alcun conto di quanto don Giulio andava così generosamente rappresentando:
«E' stabilito: domattina ci partiremo da questo monastero per il Castelnovo. Don Rodrigo attende noi tutti per concretare...» fece una pausa per esser certo l'altro capisse: «...una "Larga Intesa per la Grande Riforma", che porrà fine ad ogni sofferenza pel popolo di Napoli!
«E quando dico "tutti", sapete chi intendo, oltre voi e me!»
«Aniello Tommaso, il mercante di pesce di Vico Rotto al Mercato!» mormorò tra sé don Giulio trasalendo, come uscisse dal sogno.
Tacque, e sembrava pensare in cuor suo a quella situazione. Poi tornò a ragionare su un ultimo argomento:
«Ma quel giovane è un irruento, non tiene nulla per sacro: prima di menar oggi per il naso le folle fu ieri inquisito per aver corrotto gabellieri! Lo sentii anch'io parlare orgoglioso e arrogante domenica scorsa alla piazza, giusto dopo i primi scontri al mercato.
«Sentite, Eminenza: si eresse su un banco, dietro la cappella di Santa Croce, pestando proprio laddove, sapete, le donne del popolo portano fiori perché si tramanda che Carlo d'Angiò vi abbia eretto il patibolo a Corradino di Svevia.
«E quello che disse! L'aveste sentito! Giurò sulla testa dei figli e sulla Vergine del Carmine, attirò nel discorso San Gennaro come fosse un suo padrino, promise lavoro e fine della miseria a solo patto che tutti lo seguissero e lo riconoscessero come "capo fedele"; giurò il suo sangue a difesa dei poveri...»
«Oh insomma, don Giulio,» prorruppe spazientito il prelato: «cos'avete in quel vostro spendido capo? Ma non vi vedete d'intorno? La folla dei lazzari è inferocita. Un terzo del popolo non ha di che vivere. Tra gli onesti borghesi non trovereste quatto famiglie che, uniti insieme tutti i loro suoi averi, possano acconciare a bollire un buon "pignato maritato" con tutti gli odori ed il manzo.
«Come darebbe da mangiare a chi non ha nulla, quel vostro così caro Sedile?
«Tommaso Aniello ha portato in pochi giorni dalla sua parte un quinto degli uomini di tutta Napoli, mentre gli alabardieri sono rintanati a Castello e vi bastano appena per far guardia intorno al viceré. Li avete visti, dalla vostra finestra, i fuochi? Oggi Napoli ardeva come Troja! Ma cosa credete, Genoino, che codesti vostri elaborati discorsi siano buoni a convincere le intelligenze di cotali signori?
«La sommossa deve finire! Il re franco Luigi non aspetta che di mandarci le sue navi da guerra nel Golfo. A Napoli circolano già chissà quanti sicari del cardinal Richelieu, e la Spagna, se in tale frangente fallisse Rodrigo d'Arcos, con la peste che impazza a Milano, credete manderebbe un altro Juan Alfonso di Castiglia che sappia ascoltare discorsi?
«Ciò di cui abbiamo bisogno, don Giulio, è di un Paese Normale! Cosa ce ne faremo, in tale frangente, di cotesta vostra Bella Politica?
«Insomma, Genoino, è deciso! Potete far da voi solo la Riforma? No! Credete bastanti le vostre Tesi, pur sagge e sensate? Suvvia! Si impone sia fatta una "Grande Riforma", una "Intesa assai Larga" tra tutte le forze sociali.
«La plebe è in rivolta. Vuole a morte gli eletti, incapaci e corrotti; vuole eletto un sol Capo, che sia uno dei loro, che li tuteli e protegga. Considerate ancor questo, che mi sembra pensiero assai ragionato.
«Ieri don Tiberio Carafa si mosse; e sapete: è persona come voi, laureata allo Studio. Il principe di Satriano è daccordo. La nobiltà antica ha esposto il disegno a Rodrigo. Io stesso non vedo soluzione più acconcia, ed a tutti mi espressi in tal senso.
«Voi, Genoino, dovete esser con noi, e venir domattina al Castello. I borghesi vi sanno accorto e studiato. Garantirete per loro l'Intesa.
«Rammentate: voi siete oggi non più cittadino, ma uomo di Chiesa. Aderite a quanto, quale vostro arcivescovo, io vi chiedo di fare. Per il bene di Napoli, per il bene tutti!»
«Sia fatta la volontà del Signore!»
Quando si volsero, mi videro; avvampato pel furore di quanto avevo udito e dalla fiamma del camino dovevo apparire paonazzo, più rosso di una fasolara lessata.
Soltanto lo sguardo, che il cardinale mi diresse passandomi accanto, m'impedì di narrare fino ad oggi quanto avevo allora ascoltato.
Per il restante della notte, lo accompagnai a riposare in una cella.
Questo è quanto avvenne in quel mercoledì dieci luglio del '47; e che mai ebbi cuore di narrare finché Sua Eminenza fu in vita.
Giuro a loro Signori che non inventai né trascurai alcunché.
Cosa avvenne l'indomani mattina è storia nota a voi tutti ed è scritta nelle carte del regno.
In tre lasciarono il monastero alla volta del Castelnuovo sulla carrozza del cardinale: don Ascanio Filomarino, don Giulio Genoino e con loro il Masaniello; quest'ultimo era giunto al Carmelo all'alba e a piedi scalzi provenendo dal Vico Rotto e ne usciva pasciuto dal refettorio carmelitano e poi calzato e vestito con gli abiti intessuti d'argento inviatigli in dono da don Rodrigo per onorare il nuovo "Supremo Capitano del Popolo Napoletano".
Le cerimonia al Castelnuovo e sul molo, i discorsi, le arringhe, i patiboli ed i bandi del nuovo Capitano, sono cose a Voi note.
Come pure ricorderete che, dopo sole quattro giornate del suo nuovo mandato (ch'egli trascorse in crociere nel Golfo, in scampagnate a Posillipo ed in assurde commissioni per l'architetto Cosimo Fanzago) il Capitano Masaniello fu sgozzato dai suoi popolani affamati.
Dopo quella sciagurata "Intesa per la Grande Riforma" la nobiltà antica riprese il controllo della Città che aveva da anni perduto: per mezzo di Palumbo e Perrone e di loro camorra, prese a lusingare la plebe ed atterrire il viceré con minacce di nuove sommosse.
Ed ebbe ben cura, fino ad oggi da allora, di mantenere agli uni e a quell'altro in sospetto i borghesi.
Quanto a don Giulio, non ebbe vita a bastanza per vedere il Sedile tornare, da quei giorni di insensata rivolta, a riunirsi.
torna a: telodiconarrando