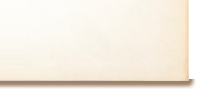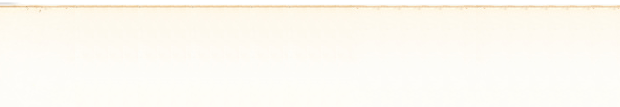
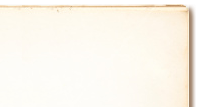

La Città Geniale
un commento a Elena Ferrante…
-------------------
Se ho deciso di annoiarvi con questa mia riflessione sul romanzo "l'amica geniale", di Elena Ferrante, lo faccio per compartire un pensiero che mi si sta formando nella mente e che non ho ancora letto nelle numerose analisi che di questo romanzo sono state scritte.
Per sintetizzare in poche parole la trama che si snoda in quattro volumi e oltre 1700 pagine, posso dire che il romanzo della Ferrante vive dentro la mia città ed abbraccia un arco di tempo che è tutta la mia vita. Quindi, racconta della mia vita …come della vita di ciascuno che mi è concittadino e quasi coetaneo.
Devo dire che sento Elena estremamente vicina. Quasi l’abbia conosciuta, incontrata, ci abbia parlato. E, forse, è successo davvero.
Eppure, il suo modo di vedere la realtà che entrambe abbiamo condiviso mi è totalmente e fascinosamente sconosciuto. Il romanzo mi ha fatto rivivere tutta la mia vita, a partire dai primi ricordi materiali d’infanzia (fino a ritrovare l’odore polveroso della calce dei muri ed il sapore rugginoso delle ringhiere dei balconcini). Ma, con il suo stile narrativo, feroce e diretto, Elena Ferrante mi ha mostrato la mia storia da un punto di vista totalmente sconosciuto. Aprendomi gli occhi.
Innanzitutto, per un motivo di genere. La visione del mondo femminile di Elena, complice e competitivo, è fabbricato intorno ad un bisogno ossessivo di controllo sulla mente, sulle persone, sulle cose, sugli eventi; un’ossessione che si trasforma in crisi d’angoscia per ogni occasionale perdita di compattezza dei propri pensieri…
È un mondo di relazioni vissute attraverso il legame fisico di carne e di sangue tra madri e figlie, che scorre tra le generazioni attraverso placente ed ombelichi. Un legame che necessariamente esclude i maschi e ne fa decorativi ed amabili (talvolta inutilmente violenti, ma comunque sempre patetici e sterili) pendagli di questo maestoso albero genealogico vivente…
Ma questa ottica da un mondo femminile che pure ricordo, da spettatore estraneo, di avere in tempi remoti intuito (sono pursempre parte di una famiglia ebrea) mi era comunque scontata, attesa, avendo letto anche altro di Elena.
No. Nel romanzo “l’amica geniale” c’è dell’altro. Ciò che di straordinario mi svela il romanzo è l’inatteso punto di vista del mondo, del mio mondo, visto dalla parte del Rione, con gli occhi di chi è (o è stato) “plebe”.
CITO:
- «Maestra: lo sai cos’è la plebe?
Lenù: sì la plebe, i tribuni della plebe, i Gracchi…
Maestra: La plebe è una cosa assai brutta.
E se uno vuole restare plebe lui, i suoi figli, i figli dei suoi figli, non si merita niente».
«Cos’era la plebe lo seppi in quel momento… la plebe eravamo noi. La plebe era quel contendersi il cibo insieme al vino, quel litigare per chi veniva servito prima e meglio, quel pavimento lurido… la plebe era mia madre, che aveva bevuto e ora si lasciava andare…».
Dunque, a me il libro ha dato molto: mi ha aperto alla conoscenza di un mondo, di una cultura, che ho sempre avuto vicina, ma che al tempo stesso ho sempre ignorato.
Come ho più volte considerato, Napoli è un luogo allo stesso tempo meraviglioso ed orribile, dove due popoli convivono senza mai incontrarsi. Ciascuno con la sua cultura, i suoi miti, la sua lingua, i suoi opposti valori.
Io sono napoletano del Vomero. Non ne ho merito, non ne ho colpa: solo fortuna.
Nella mia cultura di vomerese, Napoli (ed anche il Mondo; per dirla in breve: il mio orizzonte) è il panorama dal mio balcone.
Un golfo rotondo, pieno di vita, pieno di arte, pieno di luce. Quattro punti cardinali descrivono la quotidiana passeggiata del sole sopra la mia testa: il sole sorge a Vesuvio, tramonta a Posillipo; a mezzogiorno sta di faccia a me, proprio al di sopra di Capri. Alle mie spalle, il sole pernotta a Sant’Elmo.
Eppure, ho poi imparato che Napoli è anche la città dei quartieri (addò ’o sole nun se vede).
È anche la città di un popolo dolente che si arrampica sulle ripide pareti dei vicoli per ottenere un poco di luce.
Questa schizofrenica coabitazione è molto antica; è descritta bene da Raffaele La Capria nel suo “l’Armonia perduta”.
Io tentai di descrivere questa doppia identità della Città a parole e soprattutto con un’immagine: quella della sirena Partenope, nella copertina della mia novella del ’93. Quell’essere ibrido e mitologico sintetizzava per me la doppia natura (razionale e materna; ma al tempo stesso istintuale e distruttiva) dei suoi due popoli che convivono nel ventre della Città-femmina.
Ecco: Elena Ferrante mi ha dato una nuova descrizione della doppia natura di Napoli, interpretata dalle due amiche Lila e Lenù. È facile intuire che la storia delle due bambine (e poi ragazze, e poi donne e poi adulte), che si riconoscono reciprocamente una differente “genialità”, il cui destino si divide al momento del diploma di scuola elementare, è in realtà la storia di un unico soggetto.
E questo unico organismo dalla doppia e conflittuale natura (una colta, internazionale, aperta e disponibile; l’altra istintuale, gretta, ossessiva e manipolatrice) è in definitiva la Città Madre.
Il romanzo è dunque la metafora di Napoli e della sua cronica, patologica, schizofrenica, dissociazione culturale.
Se è così, come io credo, allora la volontaria e definitiva sparizione di Lila, a cui peralto era stata sottratta la possibilità di propagazione per linea femminile, che con un gesto inaspettato e risarcitorio lascia pieno campo alla sola Lenù, diventa per me una salvifica profezia per Napoli.
Inshallà (vuless ‘o cielo)!...
|
Pisa, ottobre 2018 |
torna a: telodiconarrando