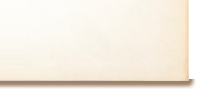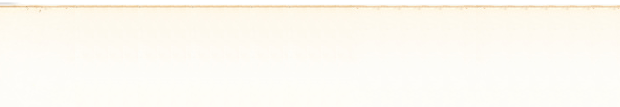
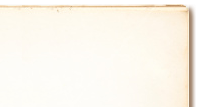

1 L'isola delle Sirene
---------------
 |
... come potrò dimenticarti, se mi sciogli e mi leghi a te? ... Grazia Di Michele, "Sha la la", 1987 |
Sul viso del portiere, cui porgo la chiave della camera tre-zero-uno, vedo stamparsi un'espressione di partecipe curiosità; poche ore fa, ben dopo la mezzanotte, mi ha visto rientrare in albergo sfoggiando una cravatta a farfalla di seta viola ed ora, poco dopo l'alba, sto uscendo in tuta e scarpe da ginnastica. Ma è solo un attimo: senza lasciarsi sfuggire altro che un saluto ed un augurio di buona passeggiata, la compassata maschera professionale riprende il sopravvento.
Oltre la porta a vetri, appena in strada, mi accoglie l'aria fresca, la luce del mattino e l'atmosfera, tutta particolare, di Capri. Ritrovo il piacere di una vecchia abitudine: di quando, bambino, esploravamo con mia madre e mia sorella i luoghi delle nostre villeggiature nelle prime ore del giorno, rientrando poi in tempo per fare colazione con gli altri appena alzati.
Allora, quelle passeggiate mi apparivano faticose, sia per lo sforzo di alzarmi presto, sia per la difficoltà di star dietro al passo svelto di mia madre. Ma il compenso era nel poter cogliere, dei posti, della gente e della natura, aspetti altrimenti e in altre ore sconosciuti; era, ed è, come se, nell'aria complice che segue la nottata, ciascun luogo si offra indifeso, incline alla confidenza.
Io, poi, stamani, sono altrettanto disposto nei confronti di Capri: dopo molti anni ho di nuovo trascorso una notte sul mio Golfo.
Mi affretto: tra poche ore inizieranno i noiosi lavori del congresso, e voglio sfruttare tutto il tempo che ho a disposizione per catturare, negli occhi e nella memoria, quanto più possibile di quest'isola, parte di me, ma che conosco appena. Quasi correndo, in breve giungo sotto l'arco da cui, lungo il muro esterno della Cattedrale, mi immetto nella piazzetta, che è già tutta un viavai di tavolini e sedie e camerieri indaffarati a sistemare per l'apertura dei bar. La funicolare è in funzione. Sotto la torre dell'orologio l'edicola è invece ancora chiusa: i giornali arriveranno col primo traghetto.
Per la scalinata di lato a San Michele due anziani, senza fretta, chiacchierando s'incamminano. A tratti s'arrestano; per dar modo ora a l'uno ora all'altro di esprimere, con un gesto più ampio, un concetto di maggior rilievo; poi riprendono la salita. Attraversata la piazzetta, dalla terrazza mi affaccio sulla vallata che degrada verso il porto. Mi sovrasta la mole del monte Solàro, i cui balzi erti sono rotti solo dalla strada che, sospesa, li attraversa per portare ad Anacapri.
Questa via è l'unica che colleghi i due giganteschi e ripidi scogli calcarei di cui l'isola è costituita (il monte di Tiberio ed appunto il Solàro) ed anche relativamente recente: quando la mia bisnonna Barbara era bambina ad Anacapri, questa strada non era ancora aperta; solo una interminabile scala, che tre millenni prima i Fenici avevano intagliata gradino per gradino nella roccia di calcare, congiungeva il paese al porto ed al resto dell'isola.
Della mia bisnonna conosco il racconto che ne fa mia madre: una vecchia di altra epoca, che parlava solo il dialetto (che sulle sue labbra aveva la grazia e l'orgoglio di una lingua nobile e ingiustamente decaduta) e pretendeva il Voi, anzi il Vuje, da figli e nipoti e che, insegnando a lei piccola il ricamo, la puniva duramente per ogni disattenzione.
Ma ora la vedo bambina, occhi e capelli nerissimi, che a piedi scalzi trotterella giù per quei gradini dietro il padre che, nella sua compunta uniforme di uffiziale delle Regie Poste (Borboniche prima, Savoja poi), scende verso Marina Grande, incontro al traghetto postale della mattina.
Come dovunque sul Mediterraneo, di quante straodinarie opere d'ingegno edificarono i Fenici, oggi di quella scala restano solo rovine.
Ancora uno sguardo dalla terrazza, verso il porto ed oltre, sul mare; purtroppo è una giornata di foschia. Non posso certo lamentarmi del tempo: difatti è un ottobre molto mite, e di giorno il sole scalda come d'estate. Ma questa nebbia mattutina mi impedisce ora di vedere Napoli.
-
Dall'altro lato del Golfo, in mezzo al mare, al margine
dell'orizzonte, la figura
inconfondibile di Capri dalla mia finestra è stata per anni
una presenza
familiare; come la Luna, che da sempre ci orbita attorno, ho
spesso considerato
quest'isola il satellite naturale di Napoli. Ora, da Capri, gioco
a immaginarmi un astronauta che scruta la Terra dall'altro capo
del cielo.
La mia mèta è l'arco naturale e la grotta di Matromània; ritorno nella piazzetta e imbocco una piccola vòlta che si apre di fianco al palazzetto del Municipio.
Le stradine, le scalette, le voltine, gli archetti (per descrivere i particolari urbanistici del borgo occorrono solo diminutivi) che percorro o, per meglio dire, in cui mi addentro, mi trasmettono un senso di attento riguardo; e mi sorprendo a camminare con circospezione.
Colgo in questo le tracce dell'influenza esercitata da Amalfi su Capri nei brevi secoli della sua potenza marinara: ne è segno questo borgo, non difeso da mura ma dalla sua stessa struttura.
Inerpicarsi nel dedalo di viuzze anguste e impervie, sotto vòlte e finestre e balconcini aggettanti scoraggerebbe qualsiasi sarracino dal tentarne l'assalto.
Ora la prospettiva si allarga: uscendo dall'abitato la stradina offre da un lato una vista sul mare, e costeggia dall'altro una sequela di ville.
Queste, tutte tra loro diverse, presentano però nel bianco degli intonaci a calce, nell'uso ornamentale della maiolica dei colori del mare e soprattutto nelle animate architetture delle coperture a volte estradosse, costanti richiami a gusti moreschi. Costruite tutte ben dopo che le scorrerie dei pirati saraceni erano cessate, i particolari di queste case non sono a testimoniare i gusti orientali degli invasori, ma del sollievo per lo scampato pericolo.
Passo accanto ad un ristorante, chiuso e deserto. Qui, dove ora è un fitto bosco di zampe di seggiole rivoltate sui tavoli, ieri sera cenavo in piacevole compagnia di amici, mentre duje viecchi prufessori 'e cuncertino con violino e chitarra si esibivano nel più classico repertorio napoletano.
Ho sempre detestato questo tipo di esibizioni musicali nei ristoranti: sdolcinati acquarelli di folklore partenopeo, immagine falsa di spensieratezza ad ogni costo.
Proseguo nella mia passeggiata; ora incrocio bambini con libri sottobraccio: le scuole ormai apriranno a minuti. Passato il quadrivio con la via di sopramonte, la strada diventa quasi un sentiero e si inoltra in un rado bosco di pini. La direzione è indicata da segnalazioni in maiolica.
Giungo ad un piazzaletto a mezza costa sul mare sul quale affaccia un solo piccolo edificio bianco, un bar di modeste pretese. L'anziano gestore, magro e curvo quasi che, più che il peso degli anni, sia la coppola di feltro blu, mal poggiata sui radi capelli, a gravargli sulla testa, l'attraversa su e giù tirando fuori sedie e tavolini che dispone di fronte, accosti alla ringhiera in legno che domina sulla scogliera. La vista del mare è solo in parte nascosta da un ripido bosco di pini, nati in poca terra tra i massi bianchi.
Ora il posto è deserto, ripieno solo dell'odore di salmastro e della resina di pino, di muschio e di caffè tostato. Ma forse durante il giorno qualche cliente onorerà questi tavolini.
Dal piazzaletto il sentiero è ora una serpeggiante scalinata in dolce discesa, sovrastata dalla bianca parete calcarea, e contornata da un basso muretto in mattoni.
L'Arco appare all'improvviso sulla sinistra, ad una svolta, mentre la vista si apre sul mare di un blu intenso.
Dei due pilastri naturali che lo sorreggono, ergendosi verticali, uno affianca il sentiero, tanto che sporgendosi sul muretto ci si potrebbe forse arrampicare; l'altro se ne discosta solo di pochi metri, per quanto è largo l'arco. Ma nel cercare il punto in cui spicca dalla scogliera, lo sguardo precipita fin quasi al mare.
All'altezza del sentiero si imposta la curvatura dell'arco, la cui sommità mi sovrasta di una decina di metri. Non è maestoso né imponente; anzi discreto, quest'arco a sesto acuto ha l'austera dignità di un'architettura gotica.
Attraverso la sua apertura si scorge in basso una piccola insenatura, nella quale il blu del mare, incontrando la riva ghiaiosa, si rompe in schiuma. Bianca tra il bianco degli scogli. La mia guida tascabile consiglia di proseguire per la scalinata che porta alla grotta di Matromània coi suoi resti romani e per il sentiero che poi, aggirato il promontorio, risale alla punta Tragàra, da cui in breve rientrerei all'albergo.
Partendo subito mi rimarrebbe tempo sufficiente per una doccia prima di colazione; tuttavia qualcosa mi trattiene qui, accucciato sul muricciolo a precipizio, le spalle appoggiate alla roccia, lo sguardo sull'arco e oltre, sul mare aperto, da cui la nebbia comincia ad alzarsi.
L'affanno per la passeggiata fatta quasi di corsa sta passando, e con esso l'impazienza che l'accompagnava. La roccia, pure fredda e aguzza contro la mia schiena, mi trasmette un senso di calma; mi guardo attorno: dovunque verdeggiano, tra il bianco del calcare, tipici arbusti dei giardini rocciosi; tutta la scogliera è un incredibile rigoglio, a dispetto della secchezza del luogo e della stagione; autunnale, altrove che da quest'isola.
Persino un piccolo pino campeggia quasi in cima all'arco; nato da un pinolo portato dal vento o caduto dall'alto, è attecchito chissà come in qualche screpolatura della pietra. Facendosi strada con le radici, nel tentativo di sopravvivere nonostante l'aridità della roccia, allargherà le crepe già aperte dal gelo invernale, staccherà ciottoli che precipiteranno in mare.
Ciottolo dopo ciottolo, quel piccolo pino, e gli altri dopo di lui, e l'acqua, il vento, il gelo disfaranno la roccia dando nuove forme alla scogliera.
Ultimo resto forse dell'imboccatura di una grotta crollata, anche quest'arco sparirà.
Da quanto esiste quest'arco e per quanto continuerà ad esistere? Eccomi qua, partito da un arbusto di pino, a galleggiare nella vastità del Tempo.
Ma nello stupirmi delle mie riflessioni, mi accorgo quasi subito che non sono del tutto fuori luogo; seduto difatti come sono con le spalle alla scalinata, non vedo la terrazza del piccolo bar, davanti al quale immagino che il vecchio abbia finito di approntare per l'apertura, e distante abbastanza da non sentirne provenire alcun rumore. Sebbene non sia piccolo l'orizzonte che ho davanti, tra la scogliera ed il suo arco, la caletta in basso, il boschetto di lato, nulla mi ricorda il tempo in cui sono.
Niente case, o cavi elettrici tesi nel bosco. Per quanto strano, né lattine rosse né cocci di bottiglia, altrimenti evidentissimi sul bianco del calcare, familiari segni della mia epoca mi sembra di vedere, pur scrutando io ora con intenzione gli anfratti della roccia sotto di me.
E allora di nuovo mi abbandono alla distesa del Tempo che, con il mare, si abbatte invariato da millenni sulla ghiaia, scandito da lente e uguali onde blu.
Come da bambino, a cercare le forme nel margine frastagliato delle nubi (ora, capovolto, vedo il profilo di un uomo; lentamente si trasforma ed è un guerriero a cavallo, si stacca dal margine della nuvola e galoppa lontano; no vola, è già un'aquila, che poi, si dissolve nel cielo...), così, sospeso, immagino nella nebbia grandi vele latine.
Su lunghi e veloci legni da guerra, o su tozze e variopinte barche da pesca, la Storia è passata tante volte di qui. Fu in un mattino d'ottobre, nebbioso come oggi, che su piccole, silenziose lance a remi un minuscolo esercito approdò in una caletta come questa che l'Arco incornicia: 'e franzesi di Re Gioacchino andavano all'assalto della fortezza che gli Inglesi, in agguato analogo, pochi mesi prima avevano presa.
E più lontano, su altre onde, veleggiavano in un altro mattino d'ottobre le grandi galere della flotta cristiana; escono dal Golfo, verso il mare aperto a estrema difesa dell'Occidente: incontro ad una flotta potente, ad una battaglia incerta, ed alla gloria, infine, nella rada di Lepanto.
E da qui transitarono anche i messi che Pilato mandava a Tiberio Augusto per informarlo che nelle inquiete province d'Oriente, un Gesù Nazareno aveva smesso di predicare.
Ormai preso da questo gioco penserei naturale che dalla nebbia possa spuntare a ll'improvviso, alta e rossa, la prua di una nave fenicia.
E mi riaffiora alla mente una leggenda (o forse un fatto vero) raccontatami anni fa, e che proprio qui, nel mare dinnanzi a questa caletta si svolgeva in un nebbioso, come oggi, mattino di ottobre di un anno tanto remoto da perdersi tra i più lontani ricordi che la Storia umana conservi.
E già la sagoma di un'antica trentaremi, ora, al largo, oltre i faraglioni mi pare di scorgere; e qui nella caletta una giovane sirena solitaria vedo giocare gareggiando con la risacca delle onde che si frangono sulla ghiaia. E ridere, ora orgogliosa della sua bravura, ora divertita dei suoi sbagli.
La mia immaginazione corre troppo lontano. E' bene che racconti i fatti con ordine ...
continua: 2 Partènope
torna a: Indice